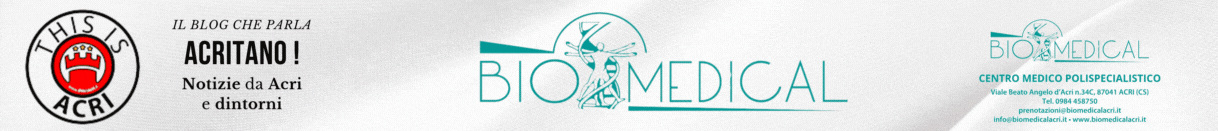ACRI SUL NEW YORK TIMES – Italo-americani alla ricerca del dialetto perduto
fonte articolo :Repubblica.it
GIAMBATTISTA Vico, filosofo italiano del XVIII secolo, credeva che a mano a mano che una civiltà progredisce perde contatto con le sue origini creative. Un antico guerriero non avrebbe mai dichiarato «sono furibondo», ma avrebbe utilizzato la metafora «mi ribolle il sangue». Il poeta Orazio nell’Antica Roma si spinse un po’ oltre: credeva infatti che quando le parole scompaiono si portano appresso i ricordi. Come le foreste cambiano fogliame ogni anno, così pure fanno le parole: nuove lingue «sbocciano e si sviluppano», ma soltanto dopo «la dipartita della vecchia progenie». Crescendo, mi sono reso conto che la lingua dei miei genitori stava avvizzendo e morendo come le foglie d’autunno. Erano immigrati negli Stati Uniti dalla Calabria alla fine degli anni Cinquanta e hanno continuato a parlare il dialetto della loro umile regione del Meridione d’Italia.
Ma la loro, ormai, era una lingua congelata nel tempo dall’esilio, piena di vocaboli che nella loro madrepatria non esistevano più. Dopo dieci anni in America, mio padre decise di comprarsi una bella automobile. In italiano un’automobile si dice «una macchina » e l’equivalente in dialetto calabrese è «‘na macchina». Ma nelle periferie pazze per le automobili dell’America postbellica, un immigrato come mio padre non poteva che rimettersi alla nazione che l’ospitava, così andò da un concessionario Chevy e chiese «‘nu carru». Il «‘nu» calabrese suona un po’ come «new», nuovo, e «carro» è proprio carro. In ogni caso, il concessionario sapeva che cosa volesse dire mio padre e gli vendette una Chevy Impala marrone del 1967. L’acquistò l’anno in cui nacqui io, il suo primogenito americano.
Il dialetto di mio padre s’infiorettava soltanto durante i suoi accessi di collera: «mala nuova ti vo’ venire» («che ti venga un accidenti »), diceva quando gli davi fastidio; «ti vo’ pigliare ‘na scuppettata» («che ti prendano a schioppettate»), e se lo facevi arrabbiare sul serio «ti vo’ brusciare l’erba » («che ti bruci l’erba sotto i piedi»). Tradurre queste espressioni improvvisate è difficile; meglio quindi immaginarle pronunciate da un uomo che avrebbe potuto sollevare un piccolo capanno degli attrezzi sul retro della casa.
Quanto a mia madre, aveva le sue erculee sfide linguistiche da affrontare. Nell’Italia che aveva lasciato non esistevano frigoriferi, e quando voleva conservare qualcosa sui blocchi di ghiaccio invece di ricorrere alla più comune parola «congelare» parlava di «frizzare», dal verbo inglese «freeze». Quando i suoi sei figli avevano la meglio su di lei, alzava le braccia al cielo e aggiungeva una vocale alla fine delle sue parole americanizzate. Così facevamo il bucato in una «uascinga mascina» (washing machine, lavatrice), pulivamo la moquette con un «vachiuma cleena» (vacuum cleaner, aspirapolvere) e bevevamo la limonata sotto al «porciu», il portico (porch).
Le battaglie che i miei genitori combattevano con l’italiano standard erano ancora nulla se paragonate alla guerra che ingaggiavano con l’inglese. A chi telefonava cercando i loro figli maschi rispondevano dicendo «she’s a no’ home»: io consideravo questa flessibilità di genere come un’affermazione della mia specificità, l’ingresso in un mondo che mi separava da tutti gli altri ragazzi dell’isolato. Noi eravamo diversi. La mia famiglia non aveva bisogno di venerare gli idoli degli immigrati di seconda e terza generazione, con i loro «mamma mia» strillati. Quando mio padre imprecava contro di me in italiano, lo faceva per la collera, non per la nostalgia.
Questa autenticità si estendeva alla tavola: i miei amici che avevano nonni siciliani parlavano di cibo italiano, ma i miei genitori lo producevano. Ogni anno preparavano centinaia di barattoli di conserve di pesche, pere e pomodori, galloni di vino rosso, e mucchi di cetrioli, piselli e patate. E poi, naturalmente, il fiore all’occhiello dell’orto: la zucca.
Un anno il quotidiano locale scattò una foto a mio padre e alle sue zucche lunghe un metro e mezzo che si erano aggiudicate un premio. Rendendosi conto di essere in mostra, mio padre rimase zitto tutto il tempo. Non comprendeva in che modo sfamare la famiglia potesse tradursi in una storia di vita vissuta. Non fraintendete: era fiero di aver coltivato un ortaggio così straordinario, e prima che scattassero le foto si assicurò di avere la riga divisoria dei capelli ben delineata. Aveva il volto rugoso e quando si fece avanti per ritirare il premio dovette appoggiarsi al suo bastone. Era sopra la sessantina, ma la vecchiaia gli era cascata addosso prima del dovuto, con un grave infarto che l’aveva lasciato paralizzato su buona parte del lato sinistro.
Mio padre fece fatica a spiegare al fotografo come avesse coltivato i suoi ortaggi. Per parlare di piante, tecniche e attrezzi poteva avvalersi soltanto di parole in calabrese. Ognuno dei suoi figli aveva raggiunto un certo livello di istruzione superiore e, così facendo, si era affrancato dagli stenti e dalla miseria che avevano costretto lui a lasciare l’Italia. A quel punto ormai noi figli ritenevamo le sue origini primordiali e remote. Egli aveva trapiantato o «trasferito» sia una famiglia sia un dialetto. E, dopo tutto ciò, si sentiva in diritto di parlare della sua zucca con parole sue. Più o meno in quello stesso periodo fece una colata di cemento accanto al suo orto, da utilizzare come basamento per un tavolo da picnic. Prima che si indurisse, firmò il cemento con uno stecco: «P. L. Nato Acri 1923». Pasquale Luzzi, nato ad Acri, Italia, 1923. Pochi mesi dopo, alla fine dell’estate 1995, morì. Nel necrologio, la passione di mio padre per l’orto fu segnalata come «hobby», parola che nel suo dialetto calabrese non esisteva.
Dopo la morte di mio padre, mi è capitato di sentirne la voce, ma non ho saputo in che modo rispondergli. Quando immaginavo di rivolgermi a lui in inglese, le mie parole suonavano pedanti e perbeniste. Rispondergli in italiano mi pareva non meno artificioso, e così pure quando cercavo di riesumare il mio dialetto calabrese o quando utilizzavo la grammatica da libro di testo che era innaturale per entrambi. Avevo moltissime cose da dirgli, ma non un modo per farlo, riflesso del nostro rapporto durante la sua vita. Senza la sue parole, stavo perdendo il modo di descrivere il mondo. All’improvviso i ricordi contavano più di quanto avessero mai contato, e non sapevo se avrei trovato le parole adatte a tenerli in vita.
Nel suo trattato sulla lingua, Dante ha scritto che anche se uomini e donne devono comunicare a parole, gli angeli possono parlarsi in silenzio. Parlare con chi è morto è la stessa cosa. Si impara subito che è meglio concentrarsi sulla persona cara che si è persa, utilizzando meno costrutti verbali possibile. Forse, il calabrese che parlo adesso con mio padre è un dialetto veramente morto, lingua che non cambia e non si traduce. Quando ora ripenso a lui, lo rivedo zappare nel suo orto, sterrando la ficuzza (in calabrese, l’amato fico) dal suo riparo invernale, per puntellarlo in vista dell’imminente primavera. Ma se dovessi esprimere a parole questa immagine, se la sua «ficuzza» diventasse «fico» in italiano standard, mio padre mi lascerebbe. Ed è a quel punto che il lutto si fa ricordo; ed è allora il momento di dire addio a una lingua e a una persona conosciute per troppo poco tempo. © 2-014, The New York Times ( Traduzione di Anna Bissanti)
DI SEGUITO LA VERSIONE ORIGINALE DELL’ARTICOLO PUBBLICATO SUL ” NEW YORK TIMES ”
Speaking to My Father in a Dead Dialect
By JOSEPH LUZZI
The 18th-century Italian philosopher Giambattista Vico believed that as a civilization progressed, it lost touch with its creative origins. An ancient warrior would never declare “I’m angry”; he would wax metaphorical with “my blood boils.” The Roman poet Horace went a step further, believing that when words died they took memories with them. Just as forests change their leaves each year, so, too, do words: new languages “bloom and thrive” but only after “the old race dies.”
Growing up, I could feel the language of my parents wither and die like autumn leaves. They had immigrated to the United States from Calabria in the late 1950s and continued to speak the dialect of their poor southern Italian region, but it was a tongue frozen in time by exile and filled with words that no longer existed in their homeland.
After a decade in America, my father decided to buy a fancy car. The Italian for a car is “una macchina,” and the Calabrian equivalent is “’na macchina.” But in the car-crazy suburbs of postwar America, an immigrant such as my father was bound to defer to his host nation. He went to the Chevy dealership and asked for “’nu carru.” The Calabrian “’nu” sounds like new, and “carro” means cart. But the dealership knew what he meant, and sold my father a maroon 1967 Chevy Impala. He bought it the year that I, his first American child, was born.
My father’s dialect flourished only in fits of anger: “mala nuova ti vo’ venire” (“may a new harm befall you”), when you annoyed him; “ti vo’ pigliare ’na shcuppettata” (“may you be shot”) and “ti vo’ brusciare l’erba” (“may the ground beneath you combust”) when you really got under his skin. It’s difficult to translate these makeshift phrases. Better just to imagine them uttered by a man who could pick up a small backyard shed.
My mother faced her own herculean linguistic challenges. There were no freezers in her Italy, so when she wanted to preserve goods on ice, she talked about “frizzare,” to freeze, rather than the standard “congelare.” When her six children got the best of her, she threw her hands up and added an extra vowel to the ends of her Americanized words. We washed our clothes in a “uascinga mascina,” vacuumed the carpet with a “vachiuma cleena,” and drank lemonade on the “porciu” — the porch.
My parents’ skirmishes with standard Italian were nothing compared to the all-out war they waged on English. They would answer calls for their sons by saying “she’s a no’ home.” I took this gender-bending as an assertion of my individuality, my access to a world that separated me from all the other kids on the block. I may have lived in a three-bedroom ranch just like everyone else, but we were different. My family had no need to worship the idols of the second- and third-generation immigrants, with their cries of “mamma mia.” When my father swore at me in Italian, he did so out of anger and not nostalgia.
This authenticity extended to the table. While my friends with grandparents from Sicily talked about Italian food, my parents produced it. Each year they churned out hundreds of jars of preserved peaches, pears and tomatoes; gallons of red wine; and bushels of cucumbers, peas and potatoes. Plus the showpiece crop, squash.
One year the local paper took a photo of my father and his prizewinning, five-foot-long gourds. Sensing he was on display, he stayed silent for the whole shoot. He didn’t understand how feeding your family could translate into a human-interest story. But make no mistake: he was proud to have created such a prodigious vegetable, and he made sure the part in his hair was just so when the picture was snapped. His face was wrinkled, and he had to lean on his cane when he reached for the prize gourd. He was only in his 60s but old age had been forced upon him prematurely by a massive stroke that paralyzed most of his left side.
My father struggled to explain to the photographer how he grew his vegetables. He had only Calabrian words for the plants, procedures and tools. Each of his children had attained some form of higher education and, with it, freedom from the strife and poverty that had chased him from Italy. We now found his background primitive and remote. He had translated or “carried over” both a family and a dialect. After all this, he believed it was his right to talk about his squash on his own terms. Around the time of the photo, he poured a cement base for a picnic table near his garden. Before it dried, he signed it with a branch: P.L. Nato Acri 1923. Pasquale Luzzi, born in Acri, Italy, 1923. He died just months later, at the end of summer in 1995. In the obituary, my father’s passion for gardening was listed as his “hobby,” a word that didn’t exist in his Calabrian.
After his death, I would hear my father’s voice but didn’t know how to respond. When I imagined myself speaking to him in English, it sounded pedantic and prissy. Answering in Italian was no less stilted, either when I tried to revive my Calabrian or when I used the textbook grammar that was unnatural to both of us. I had so much to tell him but no way to say it, a reflection of our relationship during his lifetime. Without his words, I was losing a way to describe the world. Memories suddenly mattered more than ever before, and I didn’t know if I could find the language to keep them alive.
Dante wrote in his treatise on language that though men and women must communicate with words, angels can talk to one another in silence. Speaking with someone who has died is similar. You learn early on that it is best to concentrate on the person you’ve lost with as little verbal clutter as possible. Perhaps this Calabrian I now speak with my father is the truly dead dialect, the language that neither changes nor translates.
When I think of him now, I see him digging in his garden, unearthing the ficuzza, Calabrian for his beloved fig tree, from its winter slumber and propping it up for the coming spring. But once I put a word to this picture, once this “ficuzza” becomes a “fico,” standard Italian for fig tree, he will have left me. This is when mourning becomes memory, and when it’s time to say goodbye to a language and a person I knew all too briefly.
Joseph Luzzi teaches at Bard and is the author of the forthcoming memoir “My Two Italies,” from which this essay was adapted.
Fonte : New York Times